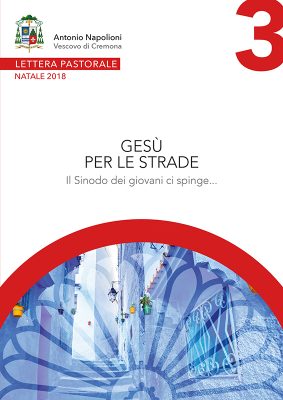Il Sinodo dei giovani ci spinge...
Gesù per le strade vorrei te cantar,
Gesù, la tua vita al mondo annunciare vorrei,
solo tu sei la vita, la pace e l’amor,
Gesù per le strade vorrei te cantar!
Gesù, per le strade vorrei te lodar,
Gesù, essere l’eco vorrei della gioia che dai,
or cantando la terra, or cantando il ciel,
Gesù, per le strade vorrei te lodar!
Gesù, per le strade vorrei te servir,
Gesù la mia croce vorrei abbracciare per te,
come il corpo e il sangue tu desti per me,
Gesù, per le strade vorrei te servir!
È un canto antico e giovanissimo, di chi scelse di vivere nel deserto e tra i poveri la comunione con Gesù, gridando il Vangelo con la vita, facendo la pastorale silenziosa e nascosta del giovane falegname di Nazareth. Come il Beato Charles de Foucauld, Carlo Carretto, i Piccoli Fratelli e le Piccole Sorelle di Gesù… Chiesa di Cremona, i tuoi giovani ti chiamano a cantare e camminare, così.
Il Sinodo dei giovani ci spinge, in avanti, con forza… come l’amore-carità di Cristo, che nel cuore degli uomini urge come esigenza insopprimibile (2Cor 5,14). Ci faccia “prendere il largo”, come ci chiedeva San Giovanni Paolo II all’inizio del millennio.
PER RIPARTIRE
Nella festa di Tutti i Santi del 2016, la Chiesa Cremonese iniziava il Sinodo dei Giovani, col desiderio di vivere “un più attento e generoso ascolto del mondo giovanile, per cogliere… i segni dei tempi che annunciano quel futuro buono che Dio ci prepara”. Nella lettera di indizione affermavo che “nei giovani possiamo scorgere il Cristo che ci viene incontro, il Signore dell’Avvento, l’Uomo nuovo sempre in gestazione. Ascoltarli davvero ci insegnerà ad ascoltare maggiormente la Parola che si incarna, sempre”.
Come hanno detto i Padri del Sinodo 2018, voluto dal Papa su “i giovani, la fede e il discernimento vocazionale”: «Crediamo che anche oggi Dio parla alla Chiesa e al mondo attraverso i giovani, la loro creatività e il loro impegno, come pure le loro sofferenze e le loro richieste di aiuto. Con loro possiamo leggere più profeticamente la nostra epoca e riconoscere i segni dei tempi; per questo i giovani sono uno dei ‘luoghi teologici’ in cui il Signore ci fa conoscere alcune delle sue attese e sfide per costruire il domani»[1].
Abbiamo avviato il percorso, cercando di coinvolgere comunità, oratori, movimenti e associazioni, alcuni ambienti della realtà sociale e delle sue periferie, soprattutto la casa circondariale di Cremona. Ora non è necessario rievocare gli sforzi compiuti e i materiali prodotti, nelle diverse fasi. Ma non posso tacere la gioia di aver visto tutti i membri dell’assemblea sinodale impegnarsi davvero, nelle 5+1 assemblee finali, in un dialogo serio e appassionato, attento agli altri e alla realtà, proteso alla ricerca del meglio, perché la nostra Chiesa sia sempre più la Chiesa bella e povera di Gesù, che vive e porta il Vangelo, coi giovani, a tutti. Grazie a tutti i “sinodali” e ai membri della Segreteria che hanno lavorato così bene.
Cosa ne pensa il Vescovo?
Nelle assemblee sono stato in attento ascolto, prendendo nota di tutto. Sul finire, i giovani mi han chiesto di dire la mia, per reagire alle loro domande e proposte. Ho chiesto tempo per riflettere, per confrontarmi con il Consiglio pastorale e con altri adulti della diocesi, rinviando ad una lettera pastorale il rilancio del dialogo e dell’impegno. È quello che cerco di fare con queste pagine, in cui recepisco le proposizioni sinodali, dimostrando quanto i giovani possono contribuire al magistero del Pastore e al cammino della Chiesa locale.
La lettera pastorale non è un riassunto del Sinodo, non è un programma, ma un messaggio che, come Vescovo, consegno con fiducia alla Chiesa di Cremona. Per rifletterci e discuterne, pregare e lavorarci insieme, da oggi in avanti.
Siamo sempre in ricerca delle tracce del Risorto, protagonista divino della nostra vita umana, tracce da riconoscere, interpretare, seguire. Mettiamoci su queste strade, lasciando ciò che ci trattiene e ci frena, per cantare, lodare e servire il Signore con tutte le generazioni.
Come leggere e usare questo testo?
Per mantenere freschezza di approccio, il testo è guidato da domande ed espressioni che ho raccolto dalla viva voce dei “giovani sinodali”. Poi, sintetizzo il messaggio che nel Sinodo lo Spirito manda alla nostra Chiesa, indicando atteggiamenti e stili cui convertirci tutti, con la grazia del Signore. Con alcuni utili rimandi al Progetto diocesano di pastorale giovanile del 2009 e ai lavori del Sinodo dei vescovi 2018. Sapendo che disponiamo già di orientamenti progettuali per la pastorale giovanile, in diocesi come nel mondo, questa Lettera cerca di darci una scossa perché il cuore si scaldi e il corpo ecclesiale si muova con coraggio. D’altronde, l’Evangelii Gaudium di papa Francesco resta la principale bussola per la conversione ecclesiale cui ci chiama oggi il Signore.
Per non mancare di concretezza, riprenderemo spesso un’ultima domanda fatta dai giovani: “E quindi…?”, indicando piste di lavoro su cui impegnarci.
- Per le strade… dei giovani
«Noi vogliamo parlare, ascoltateci»
I giovani sono problema, sfida, emergenza? No, sono sempre un dono, una risorsa, una scommessa. Il mercato sembra saperlo meglio di tutti, imponendo consumi e stili “giovanilisti” anche agli adulti (DF 34) che spesso si illudono di esorcizzare la fatica di vivere e rinunciano al gusto di essere capaci di educare. Ma, così, il rapporto tra le generazioni si ammala e va curato.
Cresce l’incomunicabilità nelle famiglie, nella scuola, nella società, nella Chiesa. Anche se non è vero che tutti i giovani fuggono, si nascondono, evitano il confronto. Spesso usano linguaggi diversi, lanciano “messaggi in bottiglia”, ma certamente guardano, e a volte urlano.
Quelli che hanno accolto l’invito al Sinodo hanno parlato, eccome! Il tempo non bastava mai, nei piccoli gruppi, in assemblea. Mi auguro che siano frequenti e profondi anche i loro dialoghi personali – sotto il cielo azzurro o tra la nebbia – “con un prete per chiacchierar”. Ma perché, poi, solo un prete? Cercasi ascoltatori e interlocutori capaci di attenzione e ascolto, che non abbiano solo voglia di predicare, correggere e comandare. Che gustino il canto della giovinezza, anche quando ha per spartito una musica che non conosciamo. Che vadano a trovare i giovani là dove sono, per ragionare della vita e del mondo da costruire, abitare, migliorare.
«E QUINDI? Praticare ancora il metodo del Sinodo,
moltiplicando le occasioni di ascolto dei giovani»
Parlateci ancora, ragazzi, abbiamo appena cominciato. E se non avessimo imparato abbastanza, guarderemo all’ascolto appassionato, empatico, amorevole di Gesù, nostro unico Maestro. Lui, “giovane tra i giovani” (DF 63), vuole incontrare i giovani per fare con loro una Chiesa che sia “la vera giovinezza del mondo”[2].
«Qualcuno ci dia spazio e fiducia»
“Avvertiamo il desiderio di essere trattati da uomini e donne e non da eterni adolescenti” (P.6[3]). Anche davanti a un bambino, ricordiamoci che è figlio di Dio adesso, persona umana, e non solo uomo o donna di domani. Gesù ha avuto fiducia nei giovani e amore per i piccoli, vedendo in essi il tipo del discepolo, che ha tutto da credere e poco da difendere. Senza dimenticare che “i giovani sono portatori di un’inquietudine che va prima di tutto accolta, rispettata e accompagnata, scommettendo con convinzione sulla loro libertà e responsabilità” (DF 66).
“Chiediamo alla Chiesa di non smettere di sperare e puntare su di noi, considerandoci capaci di collaborare e spenderci per il bene” (P.8). Quando gli occhi dei giovani sembrano delusi e critici, non temiamo di prendere sul serio i loro sguardi, e chiederci cosa non va, specie in ciò che “abbiamo sempre fatto così”. Mentre ci travolge il cambiamento del mondo, ci può uccidere il non voler cambiare nulla nella Chiesa. Non sarà il meccanico alternarsi delle generazioni a migliorare il mondo, ma la forza generativa di uno scambio, che nessuno deve temere, evitare, rinviare.
«E QUINDI? Favorire la partecipazione attiva,
anche dei giovani, ai consigli pastorali»
Il Concilio Vaticano II ha aperto una stagione di crescita nella coscienza del popolo di Dio, che a volte sembra incepparsi in forme di clericalismo ed infantilismo, che possono giovare ai poteri mondani ma non alla causa del Regno. Gesù, per bocca dei giovani e di chi ha un cuore limpido come loro, ci scuote perché la crescita continui, secondo il suo Spirito.
Possiamo e dobbiamo credere di più, pastori e laici, ai luoghi di dialogo e corresponsabilità come i consigli pastorali, e al contributo che possono portarvi i giovani. La diocesi si impegna ad affiancare parrocchie e unità pastorali perché ciò si sperimenti concretamente e con frutto.
«Aiutateci a dare un nome alla nostra sete»
Mi accorgo che sto parlando già delle solite cose di “casa nostra”, una casa che spesso si svuota rapidamente dei giovani, dopo le presenze “classificate” dei primi anni. Usciamo, piuttosto, incontro alla realtà, anche quando sembra minacciosa e spiacevole. Non c’è altra strada per incontrare i giovani: metterci al loro fianco con pazienza e simpatia, credendo che non può essersi spenta in loro la sete di infinito, la segreta ricerca di Dio. Neppure nel crescente ateismo giovanile che le indagini registrano.
Dobbiamo riconoscere che un cristianesimo senza interiorità, che coltiva solo l’epidermide della fede, non riesce a risvegliare l’esperienza di Dio nascosta dal Creatore in ogni suo figlio. Assediati dal rumore, tanti cuori non sanno ritrovare il silenzio fecondo che fa cercare e trovare Dio dentro di sé.
Può aiutare a fare un passo verso il Mistero chi sperimenta in sé desiderio di novità e di bellezza, il pungolo della conversione e della ricerca, la curiosità per ciò che lo Spirito crea e ricrea continuamente nella storia, al di là dei nostri schemi. Non è certo il moralismo la precomprensione giusta, ma una sorta di “gara a chi è più assetato di felicità piena e duratura”. Davanti a uomini e donne così, i giovani si accorgono che vale la pena rischiare il dialogo, iniziare un cammino. È stato bello riscoprirlo durante i pellegrinaggi giovanili verso Roma, lo scorso agosto, fino all’incontro tra il Papa e i suoi figli più giovani.
Lungo la strada, Gesù ci propone di vivere la parabola della paternità (Lc 15): un vero adulto esce due volte, ad accogliere il figlio minore dopo il tempo della sregolatezza e per pregare il figlio maggiore che si è irrigidito e spento. Non dobbiamo lasciare nessuno solo e assetato, nel deserto.
«E QUINDI? Chiese ed oratori a porte spalancate,
non solo per attendere, ma per andare incontro…»
Grandi educatori si nascondono ovunque, magari nella tuta di un allenatore, o nel camice di un tecnico di laboratorio, nella trasparenza di un’anziana coppia, e nella fede del più sgangherato dei preti. E se, insieme, innanzitutto la domenica, non si vede che siamo quelli che vivono l’avventura cristiana[4], dobbiamo farci qualche domanda. E riaccendere il fuoco del primo amore.
«Continuiamo a coltivare i nostri sogni»
“Chiediamo proposte formative alte, non giocate al ribasso, ma centrate sulla Parola e sul suo riferirsi alla vita, perché si possa condividere quanto essa provochi e illumini le domande profonde della nostra esistenza” (P.10). Credo che queste parole dei giovani sinodali non vogliano chiuderci in una Chiesa di élite, ma rispecchino le attese anche dei loro amici lontani dalla fede, ai quali non possiamo proporla senza mordente sulla vita e sulle sue pieghe più intime e strane.
Se abbiamo smesso di sognare e ci riduciamo alla gestione di piccoli scampoli di territorio parrocchiale… non possiamo certo aiutare a far crescere i sogni dei ragazzi. Siamo una Chiesa che sogna, desidera, crede e costruisce – col suo Dio – un Regno di pace e di giustizia, di condivisione e misericordia?
Una mamma mi ha scritto così: “Il messaggio che i giovani rivolgono al mondo adulto, in particolare a quello ecclesiale, secondo me è davvero uno sguardo al futuro, cioè far vedere loro oltre. Oltre la fatica o la difficoltà del momento”. Inoltriamoci, dunque, anche se il sentiero non sembra ben tracciato.
Se la vita è il terreno comune che ci genera e ci giudica, i sogni non saranno evasione ma speranza, laboratorio educativo e spirituale da cui dipendono il vero successo dell’esistenza personale e la qualità della convivenza umana. Lo dobbiamo sottoscrivere tutti, alla scuola del Vangelo: i nostri sogni meritano ancora attenzione e impegno. Perché quello dei giovani è il tempo delle grandi scelte di vita, che danno orientamento alla persona. È una stagione che deve poter terminare col passaggio all’età adulta, senza perdersi in un prolungamento indefinito del provvisorio (DF 68).
“Nel mondo contemporaneo, caratterizzato da un pluralismo sempre più evidente e da una disponibilità di opzioni sempre più ampia, il tema delle scelte si pone con particolare forza e a diversi livelli, soprattutto di fronte a itinerari di vita sempre meno lineari, caratterizzati da grande precarietà. Spesso, infatti, i giovani si muovono tra approcci estremi quanto ingenui: dal considerarsi in balia di un destino già scritto e inesorabile, al sentirsi sopraffatti da un astratto ideale di eccellenza, in un quadro di competizione sregolata e violenta. Accompagnare per compiere scelte valide, stabili e ben fondate è quindi un servizio di cui si sente diffusamente la necessità” (DF 91).
«Non è chiara la differenza tra noi giovani credenti e tutti i giovani»
È vero, i confini sono saltati! E forse è un bene, purché la paura non ci paralizzi ed il campo venga abbandonato. Non esistono “i giovani” in generale, tanto meno in parrocchia. Gli studi non mancano, per descrivere la cosiddetta “condizione giovanile” in tutti i suoi aspetti. Ma non producono cambiamento, se la comunità adulta non si assume le proprie responsabilità. Lo sanno bene quei genitori che scoprono il loro figlio così diverso da come lo avevano immaginato e voluto, e sono tentati di arrendersi, di sentirsi falliti. Perché non sanno chiedere aiuto, o non l’hanno trovato. Specie le ragazze ci stupiscono per la loro facile estraneità alla proposta di fede, e forse non ne abbiamo capito il perché.
«E QUINDI? Fare luce su come pensiamo,
guardiamo, parliamo dei giovani»
Non dobbiamo più parlare “dei” giovani, scrivere “su” di loro, peggio ancora lamentarci sterilmente. Spero di non correre anch’io lo stesso rischio, con questa lettera. Ci è chiesto un ulteriore bagno di realtà, faccia a faccia. Lo dico con un piccolo episodio accaduto a me: tornavo da una riunione con l’Azione Cattolica, verso le 23, e passavo dietro la cattedrale. Vedo seduti sul muretto alcuni adolescenti, qualcuno scuro di pelle, e penso a loro, con simpatia, ma passo avanti e vado verso casa. Uno di loro mi fa: “almeno buona sera!”. Mi sono girato e gli ho detto: “Hai ragione… buona sera anche a voi”. Poi ho proseguito la mia strada, mentre potevo prendere l’occasione e stare un po’ in dialogo con loro. Pensavo di disturbarli, e magari volevano essere disturbati! A letto, un po’ di rimorso mi ha accompagnato ancora.
Era “Gesù per le strade” e non mi sono fermato ad incontrarlo davvero.
«I giovani sono i migliori evangelizzatori degli altri giovani»
Il Sinodo dei giovani non deve essere un boomerang. La palla, ora, non torna solo a loro. No, scrivo alla Chiesa di Cremona, tutta intera, perché vinca ogni paura e guardi al futuro come il Signore Risorto glielo prepara. E i giovani, nella misura in cui assaporeranno la Buona notizia, se ne faranno spontaneamente narratori entusiasti ai loro compagni. O no? Il sostegno spirituale, la vita e la preghiera delle comunità, faranno la differenza.
Intanto ci dicono: “ci mettiamo a disposizione della Chiesa cremonese per testimoniare, con le nostre scelte e la nostra passione di vivere, la fede in Cristo risorto. Crediamo che il mondo porti sempre dentro di sé la sete di Dio e l’aspirazione alla felicità: siamo chiamati ad offrire il nostro contributo anche fuori dal “recinto” della Chiesa, a contatto soprattutto con quanti sono ritenuti “ultimi” e “lontani”, dentro gli impegni concreti di tutti i giorni, come la scuola, il lavoro, la società” (P.36).
Grazie, ragazzi, per questa iniezione di fiducia e di coraggio. E non dimenticate l’invito del Papa a “scendere dal divano” e a non restare chiusi in voi stessi.
«E QUINDI? Metterci sulla strada, dentro la realtà,
osando l’incontro, ascoltando ogni grido»
La strada dei giovani è la strada di Gerico, lungo la quale Gesù incontra Bartimeo, il cieco che percepisce la presenza del Messia, ma è sgridato dalla folla che si mette malamente in mezzo, diaframma tra lui e il Signore. Gesù deve cambiare atteggiamento in chi lo circonda, perché faciliti l’incontro, medi la chiamata, e quel giovane possa finalmente esprimere la sua attesa, quella di riavere la vista. La strada di Gerico è la strada lungo la quale Zaccheo sale sul sicomoro per vedere, magari senza essere visto, Gesù che passa. E la gioia entrerà nella sua casa…
- Per le strade… della fede
«Cosa significa vivere con fede?»
Il Credo, il Catechismo, il magistero della Chiesa ce lo dicono con autorità e sicurezza. Le nostre comunità sono buone custodi di grandi verità, dei tesori della fede e della liturgia. Ma questo non basta a vivere di fede, e a consegnarla vitalmente ai giovani. Per gli effetti della secolarizzazione, e perché emerge una religiosità meno istituzionalizzata, alternativa, liquida e soggettiva (DF 48-49). Perché di sola dottrina… non si riesce a raccontare Gesù e far innamorare di lui.
“Crediamo che la fede non sia semplicemente una teoria. È un dono, un seme. La paragoniamo innanzitutto ad un cammino ed è un’esperienza concreta. Ha a che fare con l’incontro con Gesù di Nazareth, il confronto diretto con lui, le sue parole e il suo stile di vita. Per noi Gesù Cristo non è un insieme di norme, ma una persona viva. E la fede non ha il sapore della risposta definitiva, ma il valore di una continua domanda: ‘cos’ha da dirci ancora Cristo?’. Il Vangelo ci provoca a cercare Dio nelle cose della vita, a chiederci: ‘perché certe cose succedono?’ e ‘che cosa abita davvero il nostro cuore?” (P.31).
«E QUINDI? Avere chiaro, caldo, al centro del cuore,
l’essenziale dell’annuncio cristiano»
Davanti a queste sollecitazioni dei giovani, rammento a tutta la comunità ecclesiale la struttura dell’esperienza di fede, in cui si devono intrecciare necessariamente:
- l’esperienza umana (fatti e domande, attese, sfide…);
- l’esperienza biblica (memoria del vangelo e della vita di Gesù, nell’esperienza di chi lo ha incontrato);
- l’esperienza di cristianesimo vissuto (nell’oggi della comunità: liturgia, carità, missione…).
Questi elementi essenziali possono articolarsi in vari modi, con diversi approcci. Non secondo una fredda formula, ma nel vivo della storia di ciascuno, bisognoso di salvezza e speranza, offerte in dono nell’incontro con Gesù, vivo qui e ora nei segni della Chiesa e nella carne degli uomini.
Educare alla fede significa, così, educare la libertà (DF 73-76) e la coscienza dell’uomo (DF 106-109), in ogni momento del suo cammino. Non sempre però i giovani – come gli adulti – sono consapevoli della delicatezza e dei margini di questo dinamismo. Non basta una vaga adesione ad un senso religioso del vivere: la Chiesa propone l’incontro con l’amore totale di Dio in Cristo, un amore gratuito e liberante. Non pratiche meccaniche né tantomeno alienazioni dal reale. Questa gratuità diviene oggi una sfida culturale, che interpella la forma della fede, la sua rilevanza, il suo posto nel cuore dell’uomo e della società. Se si sta esaurendo un cristianesimo sociologico, non dobbiamo deprimerci: si aprono le porte di un cristianesimo vitale, profetico, contagioso!
«A volte Gesù scompare dal nostro discorso di fede!»
Dono, cammino ed esperienza, incontro e domanda, tutto accade intorno al Vivente, Gesù Signore, che è presente e nascosto agli occhi degli uomini e delle donne del nostro tempo. Un po’ per scelta sua, un po’ per colpa nostra.
La religione diventa sempre più questione privata, “fai-da-te”, e anche la figura di Gesù si sfoca e confonde facilmente. Eppure, “in tanti modi anche i giovani di oggi ci dicono: «Vogliamo vedere Gesù» (Gv 12,21)” (DF 50).
Il Sinodo dei giovani ha colto alcune attuali difficoltà nei confronti della scelta di fede, e ha sollecitato a saperne rendere ragione. La questione dell’evangelizzazione è riapparsa in tutta la sua urgenza, ma in realtà la pastorale della conservazione o della sola sacramentalizzazione è ancora prevalente, a volte soffocante. Come se le “cose di Chiesa” avessero sempre la precedenza sulla persona di Gesù, che resta sullo sfondo, vago, inerte, muto. E sulla nostra vita reale, che appare spesso più condizionata dalla cultura corrente che liberata dal Vangelo di Gesù.
«E QUINDI? Ogni comunità si raduni regolarmente intorno al Vangelo,
per condividere risonanze interiori e scelte di vita»
In fondo, i nostri giovani si sono posti la stessa domanda che si poneva 50 anni fa don Luisito Bianchi, sullo scarto tra potenza del Vangelo e mediazione ecclesiale[5]. È sì questione di vita e di coerenza, ma se il Vangelo accolto da singoli e comunità per ricevere da Dio la luce calda del Suo amore, impareremmo a far nostri i suoi pensieri, opzioni e gesti, e la nostra testimonianza sarebbe diversa[6]. Tante spiritualità, che spesso assolutizzano singole idee e suggestioni, ritroverebbero forza e verità radicandosi nella spiritualità stessa di Gesù.
Se ogni porzione di Chiesa riconoscesse “Gesù per le strade”, vivo e sofferente nella realtà del mondo, si porrebbe oneste domande sulla credibilità dei propri atti e parole. E, nello stesso tempo, saprebbe dove spendere le proprie energie di carità, ponendo segni eloquenti del Regno tra noi.
«Potrebbe esserci nella Chiesa un modo sbagliato di proporre il Vangelo?»
Da Paolo VI in Evangelii nuntiandi a Giovanni Paolo II in tutto il suo magistero, da Benedetto XVI nei suoi scritti e discorsi a Francesco in Evangelii gaudium… l’insistenza sull’annuncio attraverso la vita e la testimonianza è corale. Cercasi non solo nuovi santi da venerare, ma piccoli testimoni, deboli e sereni, che raccontino ferialmente la Provvidenza di Dio.
I Papi insistono anche sulla cura delle omelie e delle catechesi, perché non siano causa di noia ma sorgente di gioia! I giovani stessi ci hanno richiamato a “custodire con libertà l’essenziale del messaggio evangelico: la fede quotidiana in Gesù, l’ascolto della sua Parola, l’esperienza della preghiera, la vicinanza ai problemi e alle sfide reali della vita” (P.9). Ma se è la nostra mediocrità spirituale a bloccare il dinamismo dell’evangelizzazione, i primi da rievangelizzare siamo noi.
«E QUINDI? Curare l’omelia perché sia fatta di “parole che fanno ardere i cuori” (EG 142).
Curare la catechesi, perché porti la luce del Vangelo sui problemi reali di oggi»
Nel mondo della post-verità e della diffidenza crescente, “occorre risvegliare in ogni realtà locale la consapevolezza che siamo popolo di Dio, responsabile di incarnare il Vangelo nei diversi contesti e all’interno di tutte le situazioni quotidiane” (DF 128). Superando la logica della delega agli “addetti ai lavori”, per sperimentare la dimensione relazionale della verità, che si manifesta innanzitutto come amicizia con Colui che “ci ha chiamato amici” (Gv 15,15), e tra noi che abbiamo scelto di seguirlo. Attorno a un Dio amico dell’uomo, la fede non si riduce a nozioni e regole, ma diviene realtà che trasfigura la vita.
«Abbiamo bisogno di parlare di noi, di come viviamo Gesù e “il nostro Spirito Santo”»
È bella questa sintesi vitale che uno dei ragazzi ha tirato fuori dal suo cuore: c’è un “nostro Spirito Santo”, ricevuto certo nel Battesimo e nella Cresima, che prende la forma originale della vita personale di ogni figlio di Dio, conformato davvero a Cristo Gesù. Questo Spirito che vuole incarnarsi e palpitare, rivelando la vocazione e animando la missione di ciascuno, rischia di non essere riconosciuto, valorizzato e messo pienamente a frutto. Come fa il mondo… nei confronti di tanti giovani. Noi non possiamo cadere nello stesso tragico errore.
«E QUINDI? Imparare la pedagogia della fede da una settimana a Taizè, Lourdes,
o ad altre sorgenti vive…»
Per questo le Proposizioni scaturite dalla quarta assemblea (specie P.33 e P.35) ricordano alcuni ingredienti degli itinerari di fede: esperienze concrete di vita e di servizio, ascolto della Parola per scoprirne il senso profondo, preghiera e liturgia belle e vere, che non abbiano fretta di imporci idee e buoni sentimenti, ma ci misurino anche col mistero del dolore, che non risparmia nessuna generazione. Non ci si scandalizzi, ma la stessa esperienza del peccato diviene luogo santo di conversione e salvezza, quando avviene l’incontro con la misericordia di Dio, il cui volto è l’umanità di Gesù, attualizzata nei membri della Chiesa. Le proposte per giovanissimi e giovani partano perciò dalla vita vera, siano voce di testimoni appassionati, favoriscano esperienze concrete.
Cresce il bisogno di accompagnamento e discernimento spirituale e vocazionale, per il quale dobbiamo farci trovare preparati e disponibili. Il Sinodo dei Vescovi ha approfondito molto questo tema, insegnando anche come armonizzare diversi aspetti dell’accompagnamento: spirituale, psicologico, sacramentale, familiare, formativo, ecclesiale e sociale… senza farsi concorrenza!
«E QUINDI? Formiamo sacerdoti, consacrati e adulti laici
disponibili all’accompagnamento e al discernimento spirituale»
La missione di accompagnare e l’arte di discernere chiedono ritmi diversi di vita alle nostre relazioni, differenziando le possibilità di ascolto e dialogo, per non chiudersi in piccole élites. Perché così Gesù si mette sulla strada a incontrare ciascuno, entra in casa, si lascia toccare, coinvolge discepoli e famiglie, e soprattutto guarda al cuore, dove sa che abita Dio.
«Raccontateci il bello della fede»
Non posso dimenticare come si riaccese in me, tra i 16 e i 18 anni, la scintilla della fede: nell’incontro con uomini e donne i cui occhi brillavano di luce quando parlavano di Gesù, progettavano scelte secondo il Suo Regno, vivevano di servizio e di comunione ecclesiale concreta.
La catechesi si fa “narrativa” non tanto quando mettiamo bei raccontini nei nostri programmi, bensì quando i volti e le mani parlano delle esperienze e degli incontri che ognuno ha vissuto, quando una domanda sorge davanti al fascino umile di uno stile di vita, quando “si vede come si amano”! Realmente e faticosamente.
“Facciamo appello a adulti disponibili a mostrarci la loro passione per la vita, fatta di lotta, gioie e fatiche: uomini e donne testimoni della fede in questa storia” (P.34). Che bello quando un oratorio è una realtà così familiare, aperta, dove lo scambio della gioia e del sostegno nella vita prevale sul ruolo, sulle regole (che pure ci vogliono!), sul mestiere e sul possesso, che può infettare anche il volontariato più gratuito. In un oratorio così, c’è davvero spazio per tutti, per la diversità, per i più fragili.
«E QUINDI? Tutte le comunità attuino le linee diocesane
per l’iniziazione cristiana»
A fronte della evidente crisi del catechismo, il nostro grande impegno nei cammini di iniziazione cristiana è benedetto quando risveglia interesse e genera questa continuità, libera e gioiosa: il bello della fede è qualcosa che sorprende, e che può sempre avvenire. I nostri incontri devono chiudersi lasciando tutti con l’appetito e la voglia di ritrovarsi ancora. Ma questo chiede sapienza nel cuore degli adulti, anche rispetto ai limiti dei percorsi catechistici, da ricentrare intorno all’incontro di ciascuno con la persona di Gesù.
Non aver paura di affiancare giovani catechisti a chi svolge da tempo questo servizio, purché si ascoltino le loro idee, se ne valorizzi la creatività, si prendano sul serio le loro domande. Imponendoci la calma e il tempo per farlo davvero.
«Partire dalla Parola!»
I giovani l’hanno ripetuto tanto, al Sinodo… nonostante siano figli della civiltà dell’immagine più che della parola. E io lo ribadisco, in questa lettera alla mia Chiesa. La lezione del Concilio, e di maestri come il card. Martini, ha ancora da essere capita e gustata, da tanti. La nostra prassi pastorale è sbilanciata, perciò disarmonica, e quindi meno bella e feconda. Ancora tante Messe (e ci dovremmo chiedere con quale dignità delle celebrazioni), comunità frammentate e disperse, con poca cura dell’ascolto fruttuoso della Parola di Dio, senza la quale non si alimenta la fede e non si rinnova la Chiesa.
«E QUINDI? Un ritmo di vita personale fondato sull’incontro con Gesù,
che ci parla nel Vangelo di ogni giorno»
“Sentiamo la necessità di educarci all’essenziale, al cuore della fede cristiana. In particolare, avvertiamo il bisogno di ripartire dalla Parola di Dio, sperimentare relazioni comunitarie sincere e fraterne, sfidarci nel servizio del prossimo” (P.3). Basterebbe questa indicazione sinodale per un serio esame di coscienza delle nostre comunità, e per rimettere al centro Lui, ascoltarlo con amore, seguirlo umilmente, chiedendo la grazia del coraggio cristiano[7].
«E QUINDI? Mettere a tema: giovani, preghiera e liturgia…»
L’essenziale è la grazia, che Dio dona a chi prega, specie a quei due o tre che si accorderanno per invocare il Padre (Mt 18,19). Quanto preghiamo gli uni per gli altri? Come pregano adulti, genitori, nonni, per i loro ragazzi? E come introduciamo i giovani alla bellezza della preghiera e al dono della contemplazione? I nostri gesti liturgici hanno profondo spessore umano e limpido senso del Mistero di Dio? Ricordando che ogni persona è capace di “celebrare dal di dentro” della propria anima, si apre un campo affascinante di impegno, in cui scopriremo ulteriormente Gesù tra noi.
La strada della fede è la strada di Emmaus, culmine dell’esperienza drammatica e salvifica dell’umanità. In quei due che se ne tornano sui loro passi, dopo il fallimento della croce, ci dobbiamo riconoscere ogni giorno, anche come generazione adulta e giovane che non sanno più dialogare, a meno di scambiarsi sterili timori e nostalgie… in attesa di qualcosa, o meglio di Qualcuno. Ma l’incontro avviene, discreto e a volte inconscio, perché la Sua Presenza è più reale del mondo intero, la Sua Parola trafigge il cuore e ridesta una memoria grata, il Suo Segno riapre l’orizzonte alla speranza e alla missione.
- Per le strade… della Chiesa
«Un po’ di coraggio, svegliatevi!»
Evidentemente, i giovani vedono nella Chiesa cremonese una paura, o una sonnolenza, dalla quale dobbiamo scuoterci. Essi non parlano della Chiesa come un estraneo, tanto meno come un nemico: “Abbiamo una percezione positiva della Chiesa, nonostante le contraddizioni e i limiti che riscontriamo nella sua storia di strumento voluto da Dio e chiamato sempre alla conversione” (P.1). E non si “chiamano fuori” dalla responsabilità che ciò comporta: “Ci sentiamo interpellati in prima persona quando per la Chiesa si invoca coerenza: il nostro metterci in gioco è vitale per la comunità e avvertiamo quanto sia prezioso per i coetanei che frequentiamo, per il mondo in cui spendiamo la nostra esistenza e per chi, più giovane, si affaccia alla vita” (P.2). Lo dicono i giovani, non tantissimi, che si impegnano nelle comunità cristiane, ma credo che in qualche modo lo pensino anche gli altri, specie quelli che vivono diverse forme di volontariato e servizio nella società. Senza fermarci al rumore di qualche albero che cade, mentre la foresta cresce, o almeno attende!
Certo, la maggioranza dei giovani oggi sembra non aspettarsi più nulla dalla Chiesa, da questa Chiesa, e sta imparando a vivere senza Dio. Nonostante “i tentativi di innovazione, spesso il fiume della vita giovanile scorre ai margini della comunità, senza incontrarla” (DF 18).
«E QUINDI? “Un deciso processo di discernimento, purificazione e riforma” (EG 30)»
“I giovani chiedono che la Chiesa brilli per autenticità, esemplarità, competenza, corresponsabilità e solidità culturale. A volte questa richiesta suona come una critica, ma spesso assume la forma positiva di un impegno personale per una comunità fraterna, accogliente, gioiosa e impegnata profeticamente a lottare contro l’ingiustizia sociale. Tra le attese dei giovani spicca in particolare il desiderio che nella Chiesa si adotti uno stile di dialogo meno paternalistico e più schietto” (DF 57). Una Chiesa più relazionale, amica e prossima, misericordiosa, capace di dialogo e testimone di vera gioia. Una Chiesa impegnata per la giustizia e per la promozione umana integrale. Una Chiesa popolo di Dio, dai molti volti, che va incontro al mondo smettendo di preoccuparsi di stare al centro, per esserne comunque fermento vivo (DF 131-132).
«Le nostre comunità, ci aiutano a sentirci parte viva e attiva?»
Sembra che gli adulti non si accorgano delle stagioni che i ragazzi attraversano in fretta, diventando grandi. Come quei genitori che pensano sempre ai “loro bambini”, evitando accuratamente di proporre loro sfide di crescita, soglie di maturazione, scommesse per la vita. Cristo Gesù, invece, come viene incontro a noi? Con l’ansia e la paura di chiedere e chiamare, o con l’autorevolezza di chi è “la via, la verità e la vita” e interpella liberamente il cuore di ciascuno, specie dei giovani? Con atteggiamento generativo e non di controllo (DF 19, 71, 129).
La “manovalanza” giovanile non manca, in alcuni momenti e spazi della pastorale parrocchiale, ma è proprio questo che i giovani ci chiedono? Essere parte viva di un organismo vivente, è molto di più, anche di più semplice, se dipende dagli sguardi e dalle parole, dai sentimenti e dai gesti, di ciascuno, non solo di chi ha compiti di guida[8]. I giovani sono capaci di lavorare in équipe, a meno che non si scontrino con un eccessivo autoritarismo degli adulti e dei ministri.
Le ferite e i passi falsi non mancano, e dobbiamo onestamente prenderne coscienza, per cambiare. Infatti, “nel mondo giovanile sono diffusi anche pregiudizio, luoghi comuni e risentimento, spesso frutto di relazioni superficiali e giudizi affrettati, ma a volte anche di delusioni che hanno lasciato un segno negativo” (P.1). Sbrighiamoci a passare con coraggio dal fare pastorale ‘per i giovani’ a fare pastorale ‘con i giovani’: “I giovani cattolici non sono meramente destinatari dell’azione pastorale, ma membra vive dell’unico corpo ecclesiale, battezzati in cui vive e agisce lo Spirito del Signore. Essi contribuiscono ad arricchire ciò che la Chiesa è, e non solo ciò che fa. Sono il suo presente e non solo il suo futuro” (DF 54).
«E QUINDI? Se questa lettera è stata scritta “con” i giovani,
allora anche in parrocchia si può…»
Meditiamo attentamente questo bel testo del Sinodo dei Vescovi: “La passione per cercare la verità, lo stupore di fronte alla bellezza del Signore, la capacità di condividere e la gioia dell’annuncio vivono anche oggi nel cuore di tanti giovani che sono membra vive della Chiesa. Non si tratta dunque di fare soltanto qualcosa “per loro”, ma di vivere in comunione “con loro”, crescendo insieme nella comprensione del Vangelo e nella ricerca delle forme più autentiche per viverlo e testimoniarlo. La partecipazione responsabile dei giovani alla vita della Chiesa non è opzionale, ma un’esigenza della vita battesimale e un elemento indispensabile per la vita di ogni comunità. Le fatiche e fragilità dei giovani ci aiutano a essere migliori, le loro domande ci sfidano, i loro dubbi ci interpellano sulla qualità della nostra fede. Anche le loro critiche ci sono necessarie, perché non di rado attraverso di esse ascoltiamo la voce del Signore che ci chiede conversione del cuore e rinnovamento delle strutture” (DF 116).
La Chiesa ‘si fa con i giovani, permettendo loro un reale protagonismo: “Non si tratta quindi di creare una nuova Chiesa per i giovani, ma piuttosto di riscoprire con loro la giovinezza della Chiesa, aprendoci alla grazia di una nuova Pentecoste” (DF 60).
«Quanto lasciamo spazio ai fratelli di esprimere ciascuno il proprio carisma?»
Il Sinodo è stato esperienza di incontro e condivisione tra giovani cresciuti in contesti diversi, ed essi, senza difficoltà, hanno gioito per questa varietà di doni e linguaggi: “Desideriamo essere coscienti dei tanti carismi che rendono bella la Chiesa e ci ricordano i modi originali di rendere vivo il Vangelo” (P.7). “Anche nella nostra diocesi esistono molte proposte e diversi cammini di fede: parrocchie, oratori, movimenti, associazioni… Qui sta la vera ricchezza della Chiesa, che ci impegniamo a conoscere meglio e valorizzare di più: sentiamo la necessità che nella nostra Chiesa siano superate diffidenze e indifferenze. Respingiamo con forza i pregiudizi che rovinano la fiducia e la serenità tra i discepoli del medesimo Vangelo” (P.37).
«E QUINDI? È tempo di unire gli sforzi, per non disperdere energie: parrocchie, associazioni e movimenti programmino percorsi più condivisi. E li verifichino.»
La capacità missionaria della Chiesa è sempre figlia della comunione che in essa si vive, come sinfonia delle diversità che lo Spirito crea. Con quali gesti e attenzioni possiamo favorire questa esperienza?
«Spero che lo stile del nostro fare sinodo diventi lo stile delle nostre comunità»
Mentre la diocesi punta sulle “unità pastorali”, è bello che i giovani abbiano già colto il valore da perseguire insieme: solo l’unità è pastorale! Il cammino verso questa mèta indicata da Gesù stesso (Gv 17,21) non è facile, e soprattutto non è impossibile né opzionale. È “direzione obbligatoria”, a costo di intervenire su ciò che in ciascuno di noi lo impedisce o lo complica. Il Progetto di pastorale giovanile del 2009 insisteva sull’autorevolezza delle proposte diocesane e sulla loro articolazione nel territorio. Stiamo provando a migliorare le dinamiche di questa pastorale di comunione, e il contributo di tutti sarà prezioso. Con un invito a non aver paura di sperimentare qualcosa di nuovo, anche guardando in giro, nelle Chiese sorelle.
«E QUINDI? Le équipe di coordinamento nelle zone, con la presenza attiva dei giovani»
Ho già scoperto splendide esperienze di comunione tra giovani di parrocchie diverse, nelle Unità pastorali e nelle zone: essi hanno nel sangue il gusto dell’unità, e possono aiutarci a costruire quel futuro che a volte ci spaventa.
«Ci piace l’idea delle parrocchie in rete!»
Nella società iperconnessa di oggi, ben vengano reti umane significative, riconoscibili nel territorio, ma non prigioniere dei suoi confini, spesso anacronistici, soprattutto per i giovani. Il mondo è il loro villaggio, e prima che lo vivano come una fuga dalla comunità, è la comunità che deve mettersi in rete con la vita che la circonda, con le storie e le risorse dei vicini, con le prospettive di futuro, che sembrano improponibili a chi non è disposto a muovere un passo fuori di casa.
Già nel 2009 si avvertiva, per il calo dei sacerdoti e per altri motivi, la necessità di oratori non chiusi in se stessi, luoghi di corresponsabilità e di incontro, secondo un progetto educativo condiviso con tutti quelli che possono metterci testa, cuore, impegno, nei vari campi in cui si esprime la crescita umana e cristiana.
«E QUINDI? Servono laici corresponsabili in oratorio, avvalendosi talvolta di figure professionali, secondo una progettazione fatta in unità pastorale»
Una rete a maglie larghe, in cui non ci si fidi sempre e solo dei “nostri”, ma si scommetta sulla passione per il bene comune e per il futuro delle comunità, insieme a chi sperimenta e pratica vie non battute[9]. Osando immaginare comunità che non ruotano solo intorno al prete, ma si riplasmano a partire dalla vita, dai doni, dai volti, dalle urgenze del Regno.
«Chiediamo più unità pastorale, e onestà nel riconoscere i propri errori»
Sì, il Sinodo non può essere un evento episodico, e tanto meno un documento da archiviare. È un metodo e un esodo: parole che hanno sempre dentro l’elemento “strada” (odós). È un popolo che cammina insieme, per uscire da una condizione di schiavitù, o comunque di umanità insoddisfacente per tutti, verso una terra promessa, lungo la via indicata da Dio. La precarietà leggera di chi cammina è più cristiana della pesantezza immobile di chi si è installato e difende i suoi spazi. Tutta la Bibbia lo racconta e lo insegna, perché noi oggi dovremmo esserne esenti?
Ciò richiede guide sagge, profetiche e coraggiose, e soprattutto una coscienza collettiva, di cui è ognuno è responsabile per la sua parte. Il Seminario sta impostando così il cammino formativo dei futuri sacerdoti. Verso un presbiterio che, nel confronto e nella preghiera, riesca ad esprimere una sempre più unitaria coscienza pastorale, per un discernimento sapiente delle nuove sfide anche morali. “Avvertiamo il desiderio che tutti ci riscopriamo corresponsabili nella comunità ecclesiale, scegliamo con più coraggio cammini di formazione e momenti di servizio, troviamo spazi di vero protagonismo” (P.4).
Per questo, non temeremo di stare davanti alla complessità delle questioni, continuando a praticare il metodo sinodale nel riprendere i principali temi sollevati.
Il presbiterio intorno al Vescovo, con l’aiuto dei diaconi, resta la matrice decisiva della vita di comunione nella diocesi. Cominciando dalla cura di sé e del prete più vicino… anche i problemi possono diventare opportunità.
«E QUINDI? Priorità della vita di presbiterio e dei principali appuntamenti diocesani»
Le famiglie, meglio se riunite in gruppi e percorsi parrocchiali o associativi, insegnano il linguaggio della condivisione e della cura dei più deboli, manifestando la Chiesa che vive nelle case degli uomini. Le celebrazioni dell’eucaristia domenicale nelle parrocchie, come le principali convocazioni diocesane in cattedrale, sono fonte e culmine della vita di quell’organismo vivente, umile e bellissimo, che è la Chiesa di Dio in Cremona.
La strada della Chiesa è la strada di Gerusalemme, la città della pace, la cui profonda nostalgia mette in moto i piedi dei pellegrini, in attesa del compimento eterno, nella casa del Padre. Gerusalemme vive intorno al luogo della Presenza di Dio, ma allarga il suo abbraccio a tutti coloro che salgono in essa e da essa ripartono per portare pace al mondo. È la città che solo Dio costruisce con sicurezza, attraverso le mani dei suoi figli. È il luogo del Cenacolo e del Golgota, della Pasqua e della Pentecoste, mèta del cammino di Gesù e punto di partenza della missione della Chiesa.
- Per le strade… dell’amore
«Chiederci innanzitutto cosa c’è nel nostro cuore»
Il tema degli affetti ha avuto un posto centrale nel lavoro sinodale, come è giusto, se “Dio è amore” (1Gv 4,8), e se tante gioie e tanti drammi della vita di uomini e donne, famiglie e bambini, dipendono dalla buona o cattiva “gestione” dei propri sentimenti ed affetti. Per non essere in preda a tempeste emotive, blocchi e passioni incontrollabili, ciascuno è chiamato a darsi un maturo quadro di riferimento della propria realtà umana. Senza temere di farsi le grandi domande sul senso della vita. Ma non è facile.
“Come giovani sentiamo nostra la questione fondamentale: che cosa ci sto a fare qui? A nostro giudizio tutto il resto (un lavoro, la scelta della scuola…) prende senso dal modo in cui affrontiamo questa domanda. Non possiamo rimuovere la questione del senso perché o troppo giovani o troppo indaffarati. È la vita stessa a chiederci di continuare a lottare per perseguire i sogni e i desideri grandi che portiamo nel cuore, come uomini e donne di oggi e di domani” (P.22).
«E QUINDI? Rilanciamo ritiri ed esercizi spirituali, per adulti e giovani»
Il discernimento dei pensieri e dei sentimenti è arte da apprendere gradualmente, con l’aiuto di adulti che abbiano imparato ad ascoltarsi in verità, e che non cedano a tentazioni manipolatorie o paternalistiche. Non basta sapere in astratto cosa è giusto o sbagliato, se non si scava nella ricerca delle vere motivazioni che ci animano, e se non ci si apre alla “verità che libera” (Gv 8,32).
Il Sinodo dei Vescovi ci avverte di importanti metamorfosi della condizione umana, specie riguardo la corporeità, la differenza sessuale e il suo senso vocazionale. Non si tratta di reagire ideologicamente, ma di annunciare e accompagnare alla scoperta del disegno di Dio.
«Oggi più che mai c’è fame di amore»
Crescono solitudini e chiusure, ma anche svendita precoce del proprio cuore, corpo, dignità. Sotto condizionamenti potenti, sottili e pervasivi. Urge una educazione che stimi il desiderio e ne insegni la “ginnastica”, per farlo crescere verso gli orizzonti del vero bene, della pienezza di felicità, della santità. Una pedagogia della sete, della fame, che riconosca il mondo dei bisogni e lo apra a quello dei valori, troppo spesso contrapposti in maniera astratta.
La diagnosi è chiara: “Una società sempre più consumistica, un lavoro che spesso non si trova o è precario, e la necessità di spostarsi per studio o ricerca d’impiego spingono soprattutto i giovani a vivere un’affettività frammentata, a volte superficiale, impoverita. I giovani respirano un’aria provvisoria, dove c’è poco spazio per decisioni e impegni grandi, per una fedeltà intesa come progetto stabile di vita. C’è fame d’amore, ma mancano spesso un allenamento al desiderio e una cura degli affetti. Si prova paura davanti all’impegno di generare nuova vita e si è spinti a vivere di più alla giornata” (P.12). Ma di sole diagnosi non si vive e non si cresce. Di gesti concreti, di ascolti attenti, di dialoghi schietti, di preghiera sulla Parola, di percorsi condivisi, di comunità accoglienti e familiari… è fatta la risposta della Chiesa. Che c’è, anche se non è mai abbastanza.
«Se vi facessimo le nostre domande più scomode, voi siete pronti? Avete dietro qualcuno che vi prepara? … E voi giovani, volete essere davvero accompagnati in questo tema?»
Uno dei momenti di maggior schiettezza nel confronto sinodale, anche tra i giovani e i loro “don”, si è avuto intorno ai troppi silenzi sulle questioni spinose: su come “fanno l’amore” oggi i giovani, senza conoscere e apprezzare la visione cristiana della sessualità e della coppia, su tante situazioni particolari, ancora inquietanti per la complessità che comportano, sui nodi della morale e dell’educazione.
La castità prima del matrimonio e nel fidanzamento, l’omosessualità, le forme di contraccezione e di interruzione della gravidanza, sono alcuni dei temi che raramente ricevono luce nei nostri cammini formativi. Anche perché spesso non ne abbiamo creato i presupposti, in termini di clima, competenza e fiducia.
«E QUINDI? La comunità adulta si formi sulle grandi questioni antropologiche,
per poter far gustare ai giovani il vangelo dell’amore»
Ci sono sofferenze che “vengono taciute, ‘silenziate’ o non trovano luoghi di ascolto vero: prevalgono nei giovani la paura del giudizio, la vergogna e la rimozione di certe questioni, considerate fatti solo privati. Soprattutto i giovani fanno fatica ad esternare il bisogno di amare ed essere amati” (P.14).
“Chiediamo ai sacerdoti e agli adulti di non ‘evitare l’argomento’ e di essere sinceri e coraggiosi anche sulle questioni della vita affettiva, scegliendo uno stile che ispiri fiducia e stima. Desideriamo che chi ci precede nell’esperienza, non tema di impastarsi con la vita e le domande dei giovani” (P.15). Tutto il tema del rapporto dei giovani con la propria famiglia (e con la scuola) è stato difficile da approfondire nelle nostre assemblee sinodali, e richiede certamente una ripresa esplicita. Il futuro delle comunità dipende in gran parte da tale rinnovata alleanza tra famiglie e giovani, intorno alla vita e al Vangelo.
«Perché faccio queste domande alla Chiesa?»
È giusto chiederselo, mentre non esiste più un monopolio cattolico di guida morale nella società, e dobbiamo imparare a non tacere in un contesto pluralista e relativista. I giovani ci consegnano buone indicazioni per essere più efficaci in questo compito: “Chiediamo alla Chiesa di esprimersi con chiarezza sulle questioni legate all’etica della vita, senza censurare la verità per compiacenza, ma anche senza durezze giudicanti, ‘scendendo dal pulpito’: un Vangelo che proclama la bellezza e la fecondità di scelte impegnative e forti, sia la sua guida e il suo punto di riferimento. Chiediamo che nella Chiesa stili troppo drastici non alimentino discriminazioni già radicate nella nostra cultura quotidiana” (P.16).
L’educazione affettiva e morale va, dunque, proposta e attuata, sulla strada, cioè: dentro la realtà concreta, a fianco della vicenda personale di ciascuno, in una gradualità crescente, che tiene alto lo sguardo sull’orizzonte della santità, senza ignorare le ferite da curare e i massi da spostare. Nel cercare di rendere ragione dei sì e dei no della Chiesa, i giovani stessi ci aiuteranno: a loro tocca “interrogare senza vergogna e timore il Magistero, i nostri sacerdoti e gli adulti educatori, e comprendere meglio le motivazioni che stanno alla base di alcuni orientamenti della Chiesa” (P.17).
«La Chiesa ci aiuti a scoprire l’amore-per-sempre»
L’attuale crisi del matrimonio e della fecondità traccia una frontiera urgente: educare all’amore vero, facendone riscoprire la possibilità, il mistero, la dinamica. In diocesi non mancano buone prassi da diffondere. La concretezza delle problematiche chiede di non essere banalizzata in pura casistica, e ciò avverrà nella misura in cui l’annuncio del fatto cristiano potrà esprimere tutta la fecondità delle sue dimensioni.
Non è questione della sola pastorale giovanile, dunque, ma è anche questione di pastorale familiare, che non può iniziare alla vigilia del matrimonio con il solo percorso di preparazione immediata. I giovani stessi ci chiedono di esser loro vicini nella fase del “morosamento/prefidanzamento” (cfr. P.18), decisiva per impostare fruttuosamente sentimenti e comportamenti, che facciano crescere nella capacità di donarsi, unirsi, dare vita.
«E QUINDI? Farci vicini e attenti agli adolescenti e ai giovani che vivono le prime esperienze affettive, anche con l’aiuto della pastorale familiare e dei nostri Consultori»
La vocazione all’amore coniugale, al matrimonio e alla famiglia, chiede un cammino propedeutico di esplorazione dei sentimenti, che non si interrompa nelle età più delicate. Perché sacra è la vita umana[10], chiamata da Dio alla santità, alla pienezza di gioia e bellezza. Nella concreta trama di rapporti e legami, in cui ciascuno è chiamato ad uscire da se stesso, per andare verso la pienezza dell’amore.
Ed è questione che tocca, in fondo, la qualità dei rapporti tra gli adulti, nelle parrocchie e nel presbiterio. “Avvertiamo il bisogno che la questione degli affetti (relazioni stabili di stima, fraternità, amicizia, fino anche al perdono, vertice dell’amore più profondo) sia posta al centro della vita delle nostre comunità: che in esse ci si possa aiutare ad essere davvero più fratelli! Desideriamo condividere questo patrimonio anche con i nostri sacerdoti, che vorremmo più fratelli tra loro, presenti e liberi nell’affrontare con noi anche i temi affettivi. È importante che tutti, sacerdoti e laici, maturino un’affettività autenticamente libera e piena. Desideriamo che soprattutto i nostri incontri, anche di carattere formativo, curino l’aspetto prezioso delle relazioni e siano spazi di vero calore umano” (P.19).
La strada dell’amore è la strada di Betania, dove Gesù si ferma volentieri, a casa di Lazzaro, di Marta e Maria. L’amico per cui Gesù ha pianto, mostrando quanto l’amava. Le due sorelle che gareggiano, senza saperlo, nel praticare entrambi i gesti dell’accoglienza amorosa: servizio e ascolto. In quella casa, l’amore si spreca… come il profumo prezioso che Maria versa sui piedi di Gesù, quasi ad insegnare al Maestro come si ama “fino alla fine”. Da lei Gesù imparerà a lavare i piedi ai discepoli, prima di morire. Con l’amore che dà la vita per gli amici.
- Per le strade… della vita
«Scendere dal pulpito e varcare la soglia della quotidianità»
Perché “il pulpito” viene percepito così facilmente come scudo, come muro, rispetto ad un sano “stare al mondo”? Ricordo bene la differenza tra celebrare Messa in seminario, in gruppi giovanili, nei convegni… e farlo invece da parroco, domenica dopo domenica, mentre nei giorni crescevano la conoscenza delle persone, la frequentazione delle case, la condivisione spesso impotente dei dolori, l’amicizia e la familiarità con le più diverse situazioni umane. La predica, o meglio l’annuncio del Vangelo, ne guadagnava tanto, perché diventavo “portavoce della vita”, di quella della gente, oltre che del Signore della vita. Ascoltavo “Gesù per le strade” e indicavo dove continuare a riconoscerlo e seguirlo… almeno ci provavo.
Giustamente i giovani ci richiamano a “prestare attenzione al ‘come’ si comunica, al passo con l’innovazione contemporanea, senza smarrimenti e paure davanti alle novità del presente. Una buona comunicazione crediamo sia preziosa per sfatare alcuni pregiudizi nei confronti della Chiesa e della sua vita. Desideriamo siano narrati il bene e la bellezza della fede, più che la fatica e il limite” (P.11). Ma la tecnologia resta strumento, rispetto alla necessità di essere nella vita, di ascoltarne grida e musiche, di conoscerne profumi e silenzi, di praticarne insieme l’alfabeto, spesso smarrito da tanti.
«E QUINDI? Valorizzare il genio giovanile nel rinnovamento della comunicazione
nella nostra Chiesa locale»
In diocesi è stato avviato un rinnovamento delle comunicazioni sociali e dell’uso pastorale dei media, cui mi auguro che i giovani possano dare il loro contributo originale e creativo.
«La vita è di più dell’oratorio, che crescendo ci sta stretto»
C’è un pericoloso deficit di incarnazione in una pastorale che si illude per estetismi démodé, o coltiva ancora sottili ricatti pedagogici, gravi quando ci fanno svilire il vero senso dei sacramenti. La serietà delle proposte si misura da come impattano con la vita vera, in cui il Cristo ci precede e abita, prima ancora che noi ne parliamo. Ricordando che spesso è vita sbrindellata, sofferta, abbandonata, e che Gesù non se ne è mai tenuto al riparo.
“Anche il mondo giovanile è profondamente segnato dall’esperienza della vulnerabilità, della disabilità, della malattia e del dolore. In non pochi Paesi cresce, soprattutto tra i giovani, la diffusione di forme di malessere psicologico, depressione, malattia mentale e disordini alimentari, legati a vissuti di infelicità profonda o all’incapacità di trovare una collocazione all’interno della società…” (DF 43). E da noi?
Già il Progetto 2009 spiegava ampiamente come è cambiata la ferialità dei nostri oratori. E pensava ad una pastorale dei giovani (quelli oltre i 20 anni) con respiri più ampi di quell’ambiente consueto, attenta alle questioni culturali e alla dimensione vocazionale della vita.
Una proposta educativa attenta alla globalità dell’esperienza dei ragazzi, e cosciente dei ritmi di vita delle famiglie, offra diverse opportunità di incontro, spesso informali, faccia a faccia, che guardino oltre le solite attività, rispondano ai segni dei tempi, osino l’inedito. Visitando gli oratori, a volte faccio questa battuta: “dove sono le camere?”. I giovani oggi sono più disponibili a proposte intense e residenziali che a ritmi settimanali standardizzati.
«E QUINDI? Settimane comunitarie per classi delle superiori, o per gruppi,
tempi lunghi di vita comune per giovani in ricerca vocazionale,
in luoghi adatti, animati da vocazioni diverse»
“Incontri più gratuiti e feriali in Oratorio, campi, ritiri, momenti di dialogo e preghiera… sono un grande patrimonio che non va disperso e un’occasione preziosa per custodire e far crescere anche la dimensione affettiva e relazionale dei più giovani” (P.21).
Gli oratori continuino a farsi attraversare dalla vita vera dei ragazzi: siano cortili educativi, motori di incontro, alleanze educative con iniziative missionarie che parlino i linguaggi tipici della loro presenza sul territorio (sport, musica, doposcuola, animazione, spiritualità…). Rimando ai documenti del Sinodo dei Vescovi 2018 per le tante utili riflessioni sui linguaggi giovanili da valorizzare. Anche uscendo dai “nostri” spazi per abitare quelli dei ragazzi più lontani: ma c’è chi se la sente?
«È “utile” la visione cristiana della vita?»
Una domanda così è impertinente? No, è figlia del diffuso utilitarismo moderno, ma risponde anche ad un criterio squisitamente cristiano: “PER noi uomini e PER la nostra salvezza…” Dio si è rivelato e Gesù è venuto nel mondo. Questa è la somma utilità della vita cristiana, che spetta alla Chiesa dimostrare in maniera persuasiva, secondo una logica di trasparenza e irradiazione, senza ricorrere a tecniche di marketing.
Il nome cristiano della vita è, per tutti, “vocazione”. Su questo i giovani sinodali ci hanno detto cose importanti: “Oggi parlare di vocazione – intesa non come opera solo umana, ma come chiamata che Dio rivolge alla mia vita perché la vuole salva e felice – è percepito da molti giovani come cosa d’altri tempi: Dio e la sua proposta vengono spesso considerati come ‘fantasmi’ che apparterrebbero al passato. E non manca chi si chiude in se stesso davanti al presente e al futuro. Dobbiamo farci sempre provocare da interrogativi come questi: Oggi è ancora possibile vedere la vita come una vocazione? Questa parola è ben compresa?” (P.26).
La giovinezza non può restare un tempo sospeso: essa è l’età in cui i giovani devono poter prendere decisioni in ambito professionale, sociale, politico, e altre più radicali che daranno alla loro esistenza una configurazione determinante (DF 68). “Evitando di illudere i giovani con proposte minimali o soffocarli con un insieme di regole che danno del cristianesimo un’immagine riduttiva e moralistica, siamo chiamati a investire sulla loro audacia ed educarli ad assumersi le loro responsabilità, certi che anche l’errore, il fallimento e la crisi sono esperienze che possono rafforzare la loro umanità” (DF 70).
Ciò rende ancor più necessario un accompagnamento educativo che faccia scoprire e costruire un progetto di vita in chiave di vocazione, attento anche alle piccole scelte, per segnare lo stile quotidiano grazie a motivazioni profonde (cfr. P.27).
«E QUINDI? Idee concrete per la pastorale universitaria e dei giovani lavoratori»
Viviamo immersi in una “cultura dell’indecisione”, dove alla sovrabbondanza delle proposte si reagisce con uno zapping esperienziale, senza discernimento, e senza stima per l’orientamento profondo del cuore. Oppure si enfatizza il proprio progetto di autorealizzazione, spesso obbedendo a condizionamenti esterni, in chiave narcisistica. Gesù, invece, viene inizialmente a disorientare, chiamando al rischio della sequela, proponendo con amore la logica della fede e del dono, come fece col giovane ricco (Mc 10,17-22).
In un tempo di identità fragili e diluite o, per reazione, rigide e aggressive, la proposta vocazionale può spiccare come dono necessario, rispettoso e liberante.
«Come la Chiesa può aiutarci a trovare la nostra vocazione?»
Si scopre progressivamente il disegno buono che Dio ha tracciato nella vita di ciascuno, nella misura in cui si è introdotti a percepirne voce e presenza, incarnando la Parola nella trama di esperienze e sentimenti che invocano un filo rosso da non perdere. In tal senso, è importante che la catechesi dell’iniziazione cristiana sia personalizzata il più possibile, da catechisti e educatori attenti non solo ai contenuti da trasmettere e alle tappe comunitarie da attraversare, ma anche al personale ritmo di assimilazione e cambiamento che segna originalmente il passo di ciascuno.
I giovani ci chiedono di non sottovalutare la loro domanda di senso, e la loro capacità di dono: “Chiediamo che ogni attività di pastorale giovanile ritrovi il suo vero cuore nella proposta vocazionale. Il ‘come’ e il ‘dove’ orientare la vita devono essere l’anima di ogni percorso offerto in diocesi ai giovani, come pure dell’accompagnamento spirituale da parte dei sacerdoti. Sono necessari momenti e percorsi di discernimento spirituale, accessibili anche ai giovani che provengono da territori più periferici e dalle comunità più piccole. Ed è indispensabile una relazione di fiducia e di conoscenza reciproca che impegni sacerdoti e giovani” (P.28). Liberando la pastorale giovanile-vocazionale da ogni residuo alone di mero reclutamento per i ranghi ecclesiastici.
Il Sinodo 2018 propone “di offrire ai giovani un’esperienza di accompagnamento in vista del discernimento… un tempo destinato alla maturazione della vita cristiana adulta. Dovrebbe prevedere un distacco prolungato dagli ambienti e dalle relazioni abituali” (DF 161) per introdurre alla condivisione fraterna, spirituale e apostolica.
«Vogliamo vedere e vivere grinta e gioia»
La testimonianza delle vocazioni già scoperte e consacrate, la stima reciproca tra sacerdoti e religiosi e religiose, l’aria di Chiesa aperta e fiduciosa che spesso si respira, l’amicizia tra preti e sposi, il vissuto di famiglie normali e liete della fecondità cui hanno dato spazio… tante luci si accendono e rischiarano il cammino. “Grinta e gioia” sono un bel binomio, visibile in chi non ha avuto paura dei propri limiti e non si affanna per il consenso e il successo, ma si spende in mezzo ai piccoli e ai poveri, qui o in paesi lontani, secondo quello stile missionario, che distingue una vita cristiana non ripiegata su se stessa. Ricordando che è necessario un onesto riconoscimento di limiti e difficoltà, ferite e blocchi, per impostare un promettente cammino di crescita verso la maturità integrale.
La grinta e la gioia che si assaporano nei momenti forti della vita comunitaria chiedono di essere distillate e metabolizzate nel quotidiano che, altrimenti, ridiventa un deserto vuoto, luogo di tradimenti e abbandoni. Per questo, occorre proporre e acquisire il metodo della vita in Cristo e nella Chiesa, che sempre rinasce al contatto con “la dinamite della Parola” (cfr. Rom 1,16), che spinge a mettersi in gioco per il Regno, che si impregna della grazia del perdono, che assapora il gusto esigente della vita in comunione[11].
«E QUINDI? Rilancio dell’indole missionaria della nostra Chiesa,
in tutte le sue componenti»
Di nuovo, la questione non sono i giovani ma gli adulti, che essi vogliono incontrare in verità: “Avvertiamo il bisogno di confrontarci con adulti maturi e significativi, capaci di trasmetterci il fascino della fecondità e del dono di sé” (P.20). Magari, cominciando col raccogliere la testimonianza di saggezza e memoria custodita da tanti anziani. I sogni degli anziani e le profezie dei giovani accadono solo insieme (cfr. Gl 3,1), confermando la bontà delle alleanze intergenerazionali (DF 1).
Con un apprendistato lungo e profondo, con l’aiuto dello Spirito, si diventa capaci di quell’autorevolezza che nessuno può darsi da sé, col solo studio e col mero ruolo. Si diventa guide, nella misura in cui ci si è lasciati guidare. Avremo esploratori affidabili, se ognuno avrà esplorato con umiltà, in obbedienza a Dio, il proprio cuore e il mondo che lo circonda.
«E QUINDI? La domenica, nelle nostre comunità,
ha questo volto di gioia e santità?»
Qualcuno si chiede: “la gente è depressa perché va in chiesa, o va in chiesa perché è depressa?”. È in gioco la gioia, la festa, la santità, sempre: quella della Chiesa, dei suoi giovani e adulti. “Noi dobbiamo essere santi per poter invitare i giovani a diventarlo” (DF 166). “Attraverso la santità dei giovani la Chiesa può rinnovare il suo ardore spirituale e il suo vigore apostolico. Il balsamo della santità generata dalla vita buona di tanti giovani può curare le ferite della Chiesa e del mondo, riportandoci a quella pienezza dell’amore a cui da sempre siamo stati chiamati: i giovani santi ci spingono a ritornare al nostro primo amore (cfr. Ap 2,4)” (DF 167).
La strada della vita è la via dolorosa, che non è soltanto il tragitto della via crucis di Gesù e di chi lo segue nei tanti “venerdì santo” della storia. La via dolorosa è il mistero profondo dell’esistenza di ogni creatura, segnata dalla fragilità e dalla morte, sin dalle doglie del parto. E’ una vita in salita, non solo fino al Calvario, ma fino al cielo, vocazione ultima e definitiva dei figli di Dio. Non perché ci salvi la quantità del dolore sofferto, ma perché si apra il cuore – di carne, non di pietra – alla sovrabbondanza dell’amore che ci viene incontro, nella nostra debolezza. Paolo, al fine, lo capì: “Quando sono debole, è allora che sono forte” (2Cor 12, 10). E fu quella la sua piena, matura, ulteriore chiamata.
«Bisogna essere umili davanti alla realtà»
L’orizzonte delle nostre strade si allarga, e oltre al cannocchiale serve anche il microscopio, per osservare il mondo e ogni suo frammento, la Chiesa e ogni suo membro, la pastorale ed ogni suo istante.
Il cristianesimo è un fatto, un Vivente, una storia di salvezza, una realtà di Amore divino e incarnato… non una teoria con cui giudicare a priori gli eventi, senza accoglierli come dono e opportunità. Chiusi in parrocchia, rischiamo di parlarci addosso, e di non riconoscere il Viandante divino che continua a farsi pellegrino in mezzo a noi, in ogni tempo e luogo.
Se non siamo schiavi dei pregiudizi, la realtà è sempre ricca di belle sorprese, la gente è sempre più buona di come la raccontano i giornali, la vita ha sempre più risorse dei bilanci che tracciamo. Purché prendiamo sul serio tutto ciò che è umano[12].
Anche davanti alla realtà dura del male, della miseria, dell’ingiustizia, della malattia e del limite, i giovani ci chiedono di non gettare né acqua né benzina sul fuoco. Di non fingere e illuderli, di non scoraggiarli, ma di essere onesti e umili, autorevoli perché provati dall’esperienza, come ci insegnano i nostri vecchi, che non ascoltiamo mai abbastanza. Il Sinodo 2018 ha offerto indicazioni preziose per creare occasioni di rielaborazione del vissuto, in una prassi di paziente accompagnamento e formazione.
«E QUINDI? Tacere spesso per ascoltare, osservare, contemplare la realtà.
E, così, farci pace, attivamente»
In punta di piedi, mi accosto col pensiero e la preghiera a quei momenti di immenso dolore in cui i giovani, e le loro famiglie, sono messi brutalmente di fronte alla morte di uno di loro. Non possiamo lasciarli soli, né invaderli coi nostri discorsi. Ma farci fedeli compagni di viaggio, nel nome di Gesù.
«Non ascoltiamo solo le paure»
Specialmente davanti al futuro, “c’è chi cerca una direzione, mentre ad altri sembra impossibile dare concretezza alle proprie aspirazioni, soprattutto nella società odierna. I giovani spesso subiscono il disorientamento degli adulti e sono concentrati sull’adesso, prigionieri di meccanismi che li rendono incapaci di scegliere. Si è costretti a rinviare alcuni passaggi importanti (come l’autonomia dalla famiglia) e non si trovano le sicurezze cercate (ad es. un lavoro non precario). Allo stesso tempo diversi giovani sembrano immersi nell’indifferenza, mancare di senso critico e chiudersi troppo in se stessi” (P.23).
Non accettiamo più l’alibi della “crisi” e della “precarietà”. “Gesti solidali e concrete scelte di fraternità possono incidere nella storia, far rivivere la speranza nel domani e rimotivarci, quando ci avvertiamo bloccati dalla sfiducia. Anche la partecipazione da cittadini attivi alla vita pubblica è per noi un’occasione preziosa per costruire il futuro e per non relegare la fede solo all’interno dei nostri gruppi o delle nostre scelte interiori” (P.24).
«E QUINDI? Oratori e percorsi formativi diano spazio ai temi di cittadinanza attiva e
di educazione alla responsabilità sociopolitica»
In un contesto di veloce globalizzazione e migrazioni epocali, non dobbiamo temere la diversità di culture e linguaggi, mentre possiamo riconoscere e custodire l’identità propria di ciascuno, nella gratitudine per le proprie radici vitali. Purtroppo, ci inquieta il crescente tentativo – anche per vili interessi di parte – di fomentare paure e scavare fossati, costruire muri e alimentare pregiudizi, che nulla hanno di cristiano e di positivo.
«Confrontiamoci con gli ultimi, per essere provocati, non rassicurati»
Ma quale mondo conosciamo? Quello virtuale, televisivo? Quello dei voli turistici? Quello “sotto casa”? La Chiesa diventa davvero il corpo di Cristo se riparte dalle periferie, dagli ultimi, dagli scarti… sempre candidati a diventare pietre angolari (Sal 118,22).
Ci abbiamo provato, andando nel carcere di Cremona ad ascoltare chi ha sbagliato e cerca una nuova possibilità. I nostri missionari vivono sulle montagne dell’Albania, tra i pochi cristiani del Kazakistan o nei villaggi e nelle favelas del Brasile, e chi di noi ha trascorso un tempo con loro si è lavato gli occhi da incrostazioni fatte di luoghi comuni, per accogliere una verità più grande. E poi, al Sinodo, hanno partecipato attivamente anche giovani non di origine italiana, che ci hanno ricordato come cambia il mondo di oggi, e di domani.
«E QUINDI? Cantieri di servizio, aperti tra Pastorale giovanile,
Caritas, Centro missionario, società civile…»
Il tempo speso tra i malati, in un hospice, nelle case di riposo, tra i disabili, in ascolto di chi ha problemi psichici, a fianco dei disoccupati o dei migranti… è tempo sicuramente speso per il Regno. Il mondo vero, quello che in genere puzza e non profuma, quello che hanno conosciuto le generazioni passate, maturate attraverso la fatica e la prova, non è scomparso, anche se viene occultato o rimosso volentieri.
Gli stessi ragazzi soffrono… e la soglia del disagio e della devianza si abbassa pericolosamente. In oratorio spesso non vengono “i migliori”, e proprio questo giustifica ancora lo sforzo per restare aperti, se riusciamo ad offrirvi una presenza adulta attenta e propositiva. Combattendo in ogni modo la “cultura dello scarto” che pericolosamente si infiltra anche nelle nostre comunità.
Il servizio di tanti adolescenti come animatori al Grest è un buon punto di partenza per scoprire e far crescere nuove vocazioni educative, ma possiamo osare di più. “In una realtà dove si fatica ad avere interesse per l’altro, le esperienze ecclesiali (Oratorio, associazioni…) secondo il Vangelo siano punto di partenza per aiutare i giovani a impegnarsi sempre di più in attività di volontariato e di servizio come segno di inclusione nella propria comunità e apertura alla società. In un mondo che non facilita la voglia di impegnarsi per la collettività smorzando entusiasmi sempre vivi e presenti, chiediamo sostegno, collaborazione e condivisione di esperienze e metodi perché si possano coinvolgere più persone e più realtà” (P.38).
«E QUINDI? Le nostre comunità siano sempre in prima linea
nel creare più profonda integrazione tra culture, origini, storie»
L’impegno dei giovani è più facile quando risponde ad inviti concreti, specie intorno ai temi della sostenibilità sociale e ambientale, delle discriminazioni e del razzismo, anche attraverso nuove forme comunicative e di mobilitazione. In ciò, non nascondono la propria sfiducia nelle istituzioni, ed esigono dalla Chiesa coerenza e coraggio, perché non si conformi al mondo e sia davvero a fianco degli ultimi (DF 46).
Tante realtà di volontariato, non solo ecclesiali, avranno un futuro solo se si lasceranno guardare, verificare e rinnovare dai giovani, cui non dobbiamo temere di fare proposte forti e compromettenti. Adulti convinti e generosi sono capaci di farlo. E la Chiesa non tema di uscire, incontrare, seminare, condividere[13].
«Crediamo che oggi ci sia ancora spazio per stili di autentico servizio…
Ma siamo convinti di passare dall’egoismo al servizio?»
Il “fare” è tanto, ma il dubbio dei giovani è sullo stile, sulle motivazioni reali, sulla vivibilità del vangelo, in un contesto come quello attuale. L’unità tra azione e contemplazione, l’ascolto della Parola e i gesti del servizio, una efficace revisione di vita, si esigono in ogni contesto comunitario per sostenere scelte controcorrente. Per passare da una “mistica ad occhi chiusi” alla conseguente “mistica ad occhi aperti”, che riconosce il Cristo nella realtà, dura e sofferta.
Quando siamo stanchi e scoraggiati, solo il ritorno al cenacolo, all’intimità fraterna (e non privata) con Cristo Gesù, rigenera e consola. Nessuno pensi di non averne bisogno. Grati per tanti servizi e attività, i giovani ci dicono: “abbiamo bisogno di punti di riferimento che sappiano narrare con la propria esperienza come si vive in questo mondo e la bellezza che c’è nell’essere persone di fede e di speranza. È importante che sacerdoti, genitori ed educatori non si stanchino di suscitare la domanda sul domani e il suo senso, e siano disponibili ad accompagnare con libertà e convinzione la nostra sete di futuro, anche nei momenti in cui questa sembra più offuscata” (P.25).
«E QUINDI? Individuare nel territorio forme di servizio adatte anche ai giovani,
e aggiornare la proposta delle varie ministerialità e del diaconato»
Ogni famiglia, ogni contrada e quartiere, ogni svolta nel cammino del tempo, nascondono sfide e possibilità, che non pioveranno dal cielo in sorte, ma fioriranno dal terreno della nostra crescita umana, cristiana, vocazionale, in quell’avventura della vita che nessuno può delegare.
«Scoprire la dottrina sociale della Chiesa»
I giovani stessi, al Sinodo, ci hanno ricordato questa risorsa. Gli insegnamenti non mancano. Forse manca l’umiltà di fermarsi a riflettere, attingendo a fonti sicure, benché impegnative. Non sottovalutiamo i laici, le donne, i giovani. Anzi, riconosciamo che abbiamo bisogno di leggere la realtà con le loro diverse ottiche, perché la Chiesa sia integralmente a servizio dell’umanità e del suo futuro di speranza.
Dopo l’attenzione riservata in questo tempo ai giovani, la Chiesa intuisce che è urgente recuperare altrettanto ascolto nei confronti del mondo femminile. L’esperienza cremonese del “tavolo rosa” è un primo tentativo di tematizzare l’enorme ricchezza di sensibilità, passione e impegno che le donne testimoniano a vari livelli. La diocesi promuoverà ulteriori opportunità e percorsi per andare davvero in tale direzione.
I giovani ritengono che “la scelta politica non sia solo legata alla realtà partitica, ma sia un impegno quotidiano nelle cose più pratiche di tutti i giorni. La formazione cristiana è necessaria per creare anche una coscienza politica che abbia come prerogativa l’ascolto del bisogno dell’altro. È necessario staccarsi dal proprio punto di vista e collaborare per riconoscere un bene comune che deve essere raggiunto” (P.40).
La discutibile qualità del confronto politico oggi nel nostro paese esige la presenza di chi abbia questa coscienza e questo sguardo. 50 anni fa, in pieno ’68, dieci anni prima di essere ucciso dalle BR, Aldo Moro così leggeva quella congiuntura giovanile e sociale: “Vi è una nuova umanità che vuol farsi, è il moto inarrestabile della storia. Non si tratta solo di essere più efficienti, ma anche più profondamente capaci di comprensione, più veramente partecipi, più impegnati a far cogliere in noi, non solo un’azione più pronta, ma un impegno di tutta la vita, un’anima nuova che sia all’unisono con l’anima del mondo che cambia”[14].
Parole così vere e attuali costituiscono un’eredità impegnativa per tutti noi. Le consegno innanzitutto ai tanti laici impegnati nell’associazionismo e nella società, perché contribuiscano senza timore all’attuazione del disegno del Concilio Vaticano II.
La strada del mondo è la via del mare, Galilea delle genti… che valica i confini del popolo eletto e introduce al dialogo e alla missione. Il mare che Gesù attraversa più volte, su cui cammina, riportando pace dopo la tempesta. Standoci dentro, immergendosi nel mistero del male e della morte, per risorgere e darci il segno battesimale di una vita che rinasce. Il mistero pasquale è posto al centro del mondo e della storia, la croce è innalzata perché guardandola e scegliendola rinasca la speranza. Perché il mondo sappia quanto Dio l’ha amato, non solo creandolo, ma donando il Suo unico Figlio per la sua salvezza.
ALMENO TRE PASSI
Carissimi amici, vi affido queste pagine, con gioia e fiducia, perché il Sinodo diventi patrimonio di tutti, utile spinta a portare avanti il cantiere del Regno in cui il Signore ci ha coinvolto, senza nostro merito.
Come ho detto in apertura, questo non è un programma né un trattato di pastorale, ma – direi – un serbatoio di speranze e potenzialità, di riflessioni e proposte, cui attingere progressivamente, in ogni comunità, secondo le scelte pastorali corrispondenti al cammino diocesano e locale.
Per prevenire il possibile senso di dispersione e rispondere alla domanda di priorità più stringenti, segnalerei almeno questi tre compiti inderogabili per tutti:
- Una vita comunitaria, gioiosa e fraterna, in cui regolarmente ci si trovi a leggere il Vangelo e i fatti della vita, per diventare insieme discepoli entusiasti di Gesù e testimoni di carità nel mondo di oggi.
- Una passione educativa per bambini, ragazzi e giovani, che si traduca nel rilancio degli oratori e nella sperimentazione di qualcuna delle nuove proposte, anche associative e interparrocchiali.
- Un impegno di formazione permanente degli adulti, perché sperimentino personalmente il valore del discernimento spirituale e siano più capaci di accompagnare i giovani nella scoperta della loro vocazione.
Questa sintesi, con le tante altre suggestioni che Gesù per le strade ci ha mostrato e ci mostrerà, ci aiuti nel quotidiano impegno della pastorale diocesana e di tutte le sue articolazioni. Perché ciò non si riduca ad un’esortazione, i parroci, i responsabili della pastorale giovanile ai vari livelli, i servizi diocesani, i membri dei consigli pastorali e delle aggregazioni ecclesiali… ciascuno riconosca subito cosa gli è chiesto di fare, di approfondire, di cominciare.
In particolare, proprio per non sovrapporre troppi messaggi, la Visita pastorale che ho intenzione di attuare nei prossimi anni, potrebbe avere lo stesso tema e spirito: “Gesù per le strade”, in modo che i contenuti di questa lettera vengano ripresi e concretizzati, nel dialogo con ogni comunità.
CON LE PAROLE DI GIOVANNI
Il vescovo chiama in soccorso l’apostolo, quello che è vissuto più a lungo, sapiente nella fede e nell’esperienza di Dio Amore, perché non ha mai dimenticato di esser stato il più giovane a seguire il Maestro, il discepolo che Egli amava, e che aveva accesso alle profondità del Suo cuore. Lui, Giovanni, che giungendo per primo al sepolcro vuoto, ci mostra che “i giovani, per certi aspetti, possono essere più avanti dei pastori” (DF 66).
Consegnando questa lettera pastorale agli adulti e ai giovani della Chiesa cremonese, faccio mie le sue parole:
Ho scritto a voi, figlioli,
perché avete conosciuto il Padre.
Ho scritto a voi, padri,
perché avete conosciuto colui che è da principio.
Ho scritto a voi, giovani,
perché siete forti
e la parola di Dio rimane in voi
e avete vinto il Maligno.1Gv 2,14)
Ne scaturisce una benedizione, su tutti noi:
Ci sia dato di conoscere il Padre,
il Verbo che con Lui è dal principio e ha preso carne nel grembo di Maria.
Possiamo accogliere con gioia e custodire la Parola, che illumina il cammino e libera dal male.
Questa sarà la forza della Chiesa, sempre giovane
come la Vergine Madre di Gesù, che Giovanni accolse nella sua casa.
Cremona, 13 novembre 2018
Festa di Sant’Omobono
+ Antonio, vescovo
[1] Sinodo dei Vescovi, XV assemblea generale ordinaria, I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, Documento finale 64, d’ora in poi citato come DF.
[2] Concilio Vaticano II, Messaggio ai giovani, 7 dicembre 1965.
[3] Citiamo così, con la lettera P., le Proposizioni conclusive del Sinodo dei giovani della Chiesa cremonese, reperibili integralmente in Mosaico n.9/2018 e nel bollettino ufficiale La diocesi di Cremona n.1/2018.
[4] Come un controcanto profetico, mi hanno accompagnato nelle riflessioni di questi mesi le parole di don Luisito Bianchi, uno scomodo prete della nostra Chiesa cremonese, il cui travaglio pastorale ci può ancora illuminare: “Capisco, in questi ultimi tempi, come il fatto religioso, del rapporto con Dio, sia, debba essere un’avventura, un cammino senza piste tracciate, senza indicazioni che non siano quelle che Dio, nella sua signoria senza confini, riterrà opportuno, quando e come vuole, proporre” (Bianchi L., I miei amici. Diari (1968-1970), Sironi, Milano 2008, 522).
[5] “Perché non domandarsi che, se c’è impossibilità attualmente di comprensione, è forse perché il linguaggio della ‘Chiesa’ è diverso da quello di Cristo? Cioè il linguaggio della testimonianza; la Parola che si fa carne e abita in mezzo agli uomini” (Bianchi, cit. 249).
[6] “Sono convinto, ancora oggi, che un ascolto autentico della Parola di Dio da parte di un popolo di credenti rivoluzionerebbe il mondo, creando le basi per rapporti di giustizia e di amore fraterno fra gli uomini. Bisognerebbe, però, che fosse questo popolo, nel suo insieme, a interrogarsi e a confrontarsi col Vangelo e non dei singoli elementi” (Bianchi, cit. 265).
[7] “Mi sembra impossibile una via d’uscita che non sia la forza dell’Evangelo” (Bianchi, cit. 383); “lo so che Cristo non è evangelizzato, ma è sempre molto triste toccarlo con mano… C’è da prendere in mano l’Evangelo, ecco tutto, e proporlo con quei segni di credibilità che lo presentino come una cosa seria” (Bianchi, cit. 418); “è l’Evangelo, solo l’Evangelo, che può riempire questo vuoto spaventoso che regna nella Chiesa, in questa Chiesa, oggi” (Bianchi, cit. 730).
[8] “Lo Spirito soffia da ogni parte, sbattendo porte e finestre; e lo si scambia per un temporale cui si deve far fronte chiudendo porte e finestre e costellando il castello isolato da profondi fossati di parafulmini” (Bianchi, cit. 91). “Ho l’impressione che noi preti, che la Chiesa-istituzione siamo come degli autostoppisti ai margini della strada che, bivaccando, chiacchierando sul modo d’arrivare alla meta, facendo ogni tanto un timido gesto per fermare qualche auto ospitale, s’illudono di camminare, addirittura di correre. Ma restiamo lì, fermi ai bordi del mondo, chiedendo ospitalità, quando la chiediamo, a un’auto di passaggio che non è e non sarà mai nostra” (Bianchi, cit. 154).
[9] “Perché la tua chiesa non ha orecchie per ascoltare il nuovo comando d’uscire dagli accampamenti e affidarsi sicura alla tua guida?” (Bianchi, cit. 395).
[10] “Ci sono chiese un po’ ovunque, a ogni passo. Ma il sacro non è più dentro; è uscito e circola nelle vie dove c’è un passante ed è chiuso in ogni stanza dove c’è un uomo. Come proclamare questo mistero?” (Bianchi, cit. 281).
[11] “Dio ci offre il tempo per riconoscerlo nella sua Signoria e per riconoscere noi stessi; e noi ci gingilliamo sul nostro passato. Forse abbiamo paura di dire che siamo dei privilegiati, che ci è riservata una missione unica in duemila anni di cristianesimo, in un approfondimento unico del messaggio evangelico mai prima prodotto, anche a costo di far saltare le vecchie otri a contatto del vino nuovo. Penso, infatti, che cominciamo a registrare una novità del messaggio evangelico che sembrava definitivamente tramontata in formule ormai fissate e intoccabili” (Bianchi, cit. 491).
[12] “Fra tutti i mestieri che abbiamo saputo apprendere, manca quello di fare sul serio l’uomo. A livello religioso ne deriva come conseguenza di non aver saputo prendere sul serio Dio. Dio e uomo sono talmente correlativi, per il credente, che ogni insulto all’uomo ricade su Dio. Eppure, Lui è al di fuori e al di sopra dell’uomo. Come conciliare i due termini? Certo, nel Cristo ne trovo la ricomposizione. Ma Cristo è irrepetibile. Anche qui sono davanti a un mistero che posso accettare solo se posso accogliere l’uomo e metterlo al di sopra di ogni interesse, fatto, avvenimento umani. Mi posso spiegare, in questo modo, perché la Chiesa ufficiale sia praticamente tagliata fuori da queste vicissitudini di portata storica che la società sta vivendo e, contemporaneamente, non sia capace di presentare un accettabile volto di Dio” (Bianchi, cit. 588).
[13] “La mia Chiesa rimane ferma e crede di fare progressi; io rimango con un piede fermo in lei, perché mi sento questa Chiesa, e con l’altro tento di seguire la veloce corsa del mondo. Membra stiracchiate fra due forze, debbo ammettere di fare acrobazie, di slogarmi le membra come un pagliaccio, ma di rimanere fermo. E sotto il mio piede, il mondo gira; e sotto il mio piede, immerso in essa, la mia Chiesa sta ferma. Proprio come un pagliaccio che fatica a mantenersi in equilibrio sopra un rullo che gira velocemente” (Bianchi, cit. 655).
[14] Cit. in Pani G., Mezzo secolo fa: il sessantotto, in La Civiltà cattolica 4031 (2/2018) 427.
Apri il testo in formato pdf